“La
Ballata del Carcere di Reading”, composta da Oscar Wilde durante la sua
detenzione, é un lamento poetico in prosa, esistenziale:
racconta la storia dell'impiccagione di un giovane detenuto colpevole
di omicidio (“ha ucciso ciò che
ama”) e delle reazioni dei suoi compagni di pena. Nel testo si
susseguono due
parti: quella che descrive la convivenza con un condannato a morte ed
evoca il rituale assurdo e feroce
dell’esecuzione, e quella che contiene la meditazione sui mali del mondo e sulla redenzione.
“La Ballata del Carcere di Reading” è considerata una delle
opere migliori di Oscar Wilde. Di seguito il testo magistralmente tradotto da Clemente Fusero per il vecchio editore I corvi dall'Oglio datato 1962.
* * *
In Memoriam C.T.W. già soldato delle Guardie Reali a Cavallo
Obiit nel carcere di S.M. a Reading,
Berkshire, il 7 luglio 1896.
Prima edizione: Londra, Smithers, 1898, in-8°
(in luogo del
nome dell’autore, la sua sigla di carcerato: “C.3.3.”).
* * *
I
Più
non portava la scarlatta tunica,
Poiché il sangue ed il vino erano rossi,
E
sangue e vino aveva sulle mani
Allorché fu sorpreso, con la morta,
Quella
povera morta che egli amava
E uccise nel suo letto.
Camminava
frammezzo agli imputati
In un frusto e meschino abito grigio;
Aveva
in capo un berretto da cricket
E i suoi passi parevan lievi e gai:
Ma
io non vidi uomo guardar mai
Così intensamente la luce.
Uomo
non vidi che guardasse mai
Con sì intensa pupilla
La
breve tenda azzurra
Che i prigionieri chiamano cielo
E
la nuvola errante che passava
Con argentee vele.
Camminavo
con altre anime in pena
In un altro cerchio,
Pensando
se la colpa di quell’uomo
Fosse grave o leggera,
Quando
mi sussurrò dietro una voce:
“Colui sarà impiccato”.
Ah,
Cristo Iddio! Le mura del carcere
Parvero barcollare bruscamente
E
sul mio capo il cielo diventò
Come un casco d’acciaio incandescente;
Anima
in pena pur essendo io stesso,
Non potei la mia pena sentir più.
Sol
seppi quale incalzato pensiero
Gli accelerasse il passo e perché mai
Egli
guardasse il fulgore del giorno
Con sì intensa pupilla:
Quell’uomo
aveva ucciso ciò che amava,
E
quindi doveva morire.
Eppure
ognuno uccide ciò che ama,
Lo intendano tutti:
Lo
fanno alcuni con un bieco sguardo
Ed altri con parole carezzevoli,
Il
vile con un bacio,
Il prode con la spada!
Alcuni
uccidono il loro amore quando sono giovani,
Altri quando sono vecchi;
Alcuni
strozzano con le mani della Lussuria,
Altri con le mani dell’Oro:
I
migliori si servon d’una lama,
Perché così i morti più presto diventano
freddi.
Troppo
poco si ama, o troppo a lungo;
C’è chi vende l’amore e chi lo compra,
Chi
commette il delitto lacrimando
E chi senza un sospiro:
Poiché
ogni uomo uccide ciò che ama,
Ma
non per questo ogni uomo muore.
Non
muore d’una morte obbrobriosa
In un
giorno d’infamia tenebrosa,
Non
ha un nodo scorsoio intorno al collo
Ed un
panno sul viso,
Né
ritto sprofonda traverso l’assito
In uno spazio vuoto.
Non
siede vigilato giorno e notte
Da uomini silenti
Che
lo spiano quando tenta di piangere
E quando tenta di pregare,
Che
lo spiano per tema che sottragga
Al carcere la sua preda.
Non
vede, svegliandosi all’alba,
Terrificanti figure affollare la sua cella;
Il
tremante cappellano in veste bianca,
Lo sceriffo cupo e severo,
Il
governatore tutto in nero,
Gialla faccia da giorno del Giudizio.
Non
si leva con fretta miseranda
Per indossare i panni del condannato,
Mentre
un medico dalla bocca volgare lo guata
E prende nota d’ogni suo sussulto,
Palpeggiando
un orologio in cui i battiti lievi
Son come orrendi colpi di martello.
Non
conosce la sete disgustosa
Ch’empie di sabbia le fauci,
Prima
che il boia con i suoi guanti da giardiniere
S’insinui dalla porta imbottita
E
con tre cinghie di cuoio lo leghi
Sì che le sue fauci non abbiano sete mai
più.
Non
reclina la testa ad ascoltare
La lettura dell’Ufficio dei Morti
Né,
mentre il terrore dell’anima
L’assicura che non è morto ancora,
Sfiora
la propria bara inoltrandosi
Dentro lo spaventoso capannone.
Non
fissa i vuoti spazi
Traverso un piccolo tetto di vetro:
Non
prega con labbra di creta
Perché passi la sua agonia;
Né sente
sulla guancia fremente
Il bacio di Caifa.
II
Per sei
settimane il nostro soldato passeggiò nel cortile,
Col suo frusto e meschino abito grigio:
Aveva in capo
il berretto da cricket,
E i
suoi passi parevan lievi e gai:
Ma io non
vidi mai uomo guardar mai
Così
intensamente la luce.
Uomo non vidi
che guardasse mai
Con
sì intensa pupilla
La breve
tenda azzurra
Che i prigionieri chiamano cielo
E la nuvola
errante che trascina
Il suo arruffato vello.
Non si
torceva le mani
Come
i pazzi che ardiscono tentare
D’allevar la
Speranza, figlia spuria,
Nell’antro
della nera Disperazione:
Solamente
guardava in alto il sole
E
beveva l’aria del mattino.
Non torceva
le mani, non piangeva,
Né si
divincolava o si struggeva:
Beveva l’aria
quasi contenesse
Un
salutare balsamo:
Beveva a
bocca spalancata il sole
Come
se fosse vino!
Ed io e tutte
quelle anime in pena
Nell’altro
cerchio incedenti
Dimenticammo
se la nostra colpa
Fosse
grave o leggera:
Con opaco
stupore guardavamo
L’uomo
che doveva penzolar dalla forca.
Ed era strano
vederlo passare
Con
andatura così lieve e gaia,
Ed era strano
vederlo fissare
Così
intensamente la luce,
E strano era
pensare
Che un tale debito avesse da pagare.
La quercia e
l’olmo han deliziose foglie
Che a
primavera si schiudono:
Ma orrido a
vedersi è l’albero della forca,
Con
la radice morsa dalle vipere,
E, verde o
secco, un uomo ha da morire
Prima
ch’esso dia frutto!
Il più alto
posto è quel seggio di grazia
Al quale tendon tutti gli ambiziosi:
Ma chi
vorrebbe in cordone di canapa
Troneggiare
dall’alto d’un patibolo
E attraverso
un collare d’assassino
Lanciare
in cielo l’ultimo suo sguardo?
Dolce è
danzare al suono dei violini
Quando l’amore e la vita sorridono;
Danzare a
suon di flauti, a suon di liuti,
E’ delicato e raro:
Ma non è
dolce con agile piede
Ballar sospesi in aria!
Così con
occhi curiosi e congetture angosciate
Di giorno in giorno osservandolo,
Ci chiedevamo
se ognuno di noi
Non finirebbe alla stessa maniera
Poichè
nessuno può dire fino a qual rosso inferno
Possa smarrirsi la sua cieca anima.
Infine il
morto non passeggiò più
Frammezzo gli imputati
Ed io seppi
che adesso era là ritto
Nel nero banco degli accusati,
E che mai più
avrei visto la sua faccia
In
questo dolce mondo del Signore.
Come due navi
perdute che passano nella tempesta
Ci
eravamo sfiorati,
Ma senza un
cenno, senza una parola:
Non
avevamo parole da dire,
Poiché non
nella notte santa ci eravamo incontrati,
Ma nel giorno della vergogna.
Intorno a
entrambi un muro di prigione.
Due reietti eravamo:
Il mondo ci
aveva rigettato dal suo cuore
E
Iddio dai suoi pensieri:
E la trappola
di ferro che attende il peccato
Nella
sua insidia ci aveva ghermiti.
III
Dure le
pietre nel Cortile degli Indebitati,
Alte
le mura stillanti:
Ed era là
ch’egli prendeva aria
Sotto
il plumbeo cielo,
E due
guardiani gli camminavano ai fianchi
Per
tema che morisse.
O sedeva con
quelli che spiavano
Dì e
notte la sua angoscia,
Che lo
spiavano quando si alzava per piangere
E
quando si curvava per pregare,
Che lo
spiavano affinché non sottraesse
Al
patibolo loro la sua preda.
Il
governatore s’atteneva
Agli
articoli del Regolamento:
Il medico
diceva che la morte
Era
nient’altro che un fatto scientifico:
Due volte al
giorno veniva
Il
cappellano e lasciava un opuscolo.
E due volte
al giorno egli fumava la pipa
E
beveva il suo quarto di birra:
In
quell’anima intrepida non v’era
Nascondiglio
per la paura:
Spesso diceva
d’essere contento
D’aver
vicine le mani del boia.
Ma perché mai
affermasse una cosa sì strana
Nessun
guardiano osava domandargli,
Poiché chi
dalla sorte è condannato
Al
compito di guardia nelle carceri
Deve porsi
alle labbra un catenaccio
E fare del suo viso una maschera.
Altrimenti
potrebbe commuoversi e cercare
Di
porgere conforto e consolare:
E che farebbe
l’umana pietà
Rinchiusa
in una tana di assassini?
In un simile
luogo dove la parola bontà
L’anima
d’un fratello potrebbe aiutare?
Con passo
goffo e dondolante intorno al cortile
La Parata dei Pazzi scandivamo!
Non ci
importava: sapevamo d’essere
La Brigata del Diavolo:
Teste rase e
piedi di piombo
Compongono un ‘allegra mascherata.
Sfilacciavamo
corda incatramata
Con le unghie corrose e sanguinanti;
Sfregavamo le
porte e i pavimenti,
Pulivamo le inferriate lucenti:
Ogni squadra
lavava i tavolati
Tra un fragore di secchi sbatacchiati.
Cucire i
sacchi, spaccare le pietre,
Il polveroso trapano girare,
Urtare le
gamelle, urlare gli inni,
Al mulino sudare:
Ma nel cuore
d’ognuno
Tranquillo se ne stava il terrore.
Così
tranquillo, che ogni giornata
Strisciava come un’onda greve d’alghe:
E noi
dimenticammo l’aspra sorte
Che attende il folle e il tristo,
Fino a
quando, tornando dal lavoro,
Passammo accanto ad una tomba aperta.
La bocca
della gialla fossa spalancata in uno sbadiglio
Attendeva d’ingoiare una cosa vivente:
Il fango
stesso gridava per chiedere sangue
Al sitibondo cortile d’asfalto:
E noi sapemmo
che prima che l’alba imbiondisse
Un prigioniero doveva penzolar dalla forca.
Rientrammo
senza indugio, con l’anima assorta in pensieri
Di morte, di terrore e di condanna:
Il boia, con
il suo piccolo sacco,
S’allontanò pesantemente nel buio:
E ognuno
tremava infilandosi
Nella propria tomba numerata.
Quella notte
i deserti corridoi
Si gremiron d’immagini paurose,
E su e giù
per la città di ferro
Andavano passi furtivi che non udivamo;
Dalle sbarre
che occultano le stelle
Bianche facce sembravano spiare.
Egli giaceva
come chi disteso
Sogna in una ridente prateria;
le guardie lo
guardavano dormire,
Né sapevan capire
Ma non v’è
sonno per uomini che devono piangere
E che in passato non piansero mai:
E così noi –
i folli, i frodatori, i furfanti –
Facemmo quella veglia interminabile:
E in ogni
cervello, su mani dolorose strisciando,
Il terrore
d’un altro penetrava.
Ahimè, è
spaventevole
Sentire la colpa di un altro!
Nell’anima la
spada del Peccato
Ci entrava fino all’elsa avvelenata,
E come gocce
di piombo erano le lacrime che versavamo
Per il sangue non sparso da noi.
Con le loro
scarpe di feltro i guardiani
Scivolavano davanti alle porte sprangate
E dalla spia
vedevano, con occhio sgomento,
Figure grigie sul pavimento,
E si
domandavano perché si inginocchiassero a pregare
Uomini che un tempo non pregavano mai.
Tutta la
notte stemmo inginocchiati in preghiera,
Dementi che piangevano un cadavere!
Le agitate
piume della mezzanotte
Eran pennacchi sopra un carro funebre,
E amaro vino
offerto su una spugna
Era il sapore del Rimorso.
Il gallo
grigio cantò, cantò il gallo rosso,
Ma il giorno mai non spuntava;
Contorte
forme di terrore si rannicchiavano
Negli angoli dove noi giacevamo:
E tutti gli
spiriti maligni che vanno errando nella notte
Dinanzi a noi pareva folleggiassero.
Scivolavano e
passavano, scivolavano rapidi,
Come viandanti attraverso la nebbia:
Beffavano la
luna in un trescone
Ricco di giri e intrecci delicati;
Con movenze
solenni e orrenda grazia
I fantasmi tenevano convegno.
Con smorfie e
lazzi li vedemmo muoversi,
Tenendo per mano, ombre sottili:
Gira, gira,
in tumulto fantomatico
Ballarono una sarabanda:
E i dannati
grotteschi tracciavano arabeschi
Come il vento fa sulla sabbia!
Con piroette
di marionette
Sulle punte dei piedi saltellavano:
Ma con i
flauti della Paura l’orecchio assordavano,
Nella raccapricciante mascherata,
E a gran voce
cantavano, e lungamente cantavano,
Poiché cantavan
per destare i morti.
“Oh! –
gridavano. – il mondo è lungo e largo,
Ma gambe incatenate vanno zoppe!
E gettare una
volta o due i dadi
E’ un gioco da signori:
Ma non vince
chi gioca col Peccato
Nella segreta Casa dell’Infamia”.
Non eran
certo aeree parvenze
Quei buffoni che allegri sgambettavano:
Per uomini le
cui vite erano tenute in catene
E i cui piedi non potevano andare
liberamente,
Ahi, piaghe
di Cristo! Essi eran creature ben vive
E spaventose a guardarsi.
In cerchio,
in cerchio vorticosamente ballavano il valzer:
Alcuni giravano, in coppie leziose;
Altri con
passi affettati di tipi un po’ equivoci
Si dileguavano su per le scale:
E con sottili
sogghigni, con occhiatine adescanti,
Ognuno ci assisteva nelle nostre preghiere.
Il vento del
mattino cominciò a far udire i suoi gemiti,
Ma ancora durava la notte;
Sul suo
gigantesco telaio l’ordito delle tenebre scorse
Fin che l’ultimo filo fu tessuto:
E nel pregare
paura ci colse
Della giustizia del sole.
Il vento
gemebondo andò vagando
Intorno alle piangenti mura del carcere,
finché, come
una ruota d’acciaio che giri,
Sentimmo serpeggiare i minuti:
O gemebondo
vento, che cosa avevamo mai fatto
Per meritarci un simile siniscalco?
Io vidi
infine l’ombra delle sbarre
Come un traliccio lavorare in piombo
Stamparsi
sull’imbiancata parete
Di fronte al letto fatto di tre assi,
E seppi che
in qualche luogo del mondo
Già rosseggiava la terribile alba di Dio.
Alle sei
scopammo le nostre celle,
Alle sette tutto era tranquillo:
Ma il fremito
di un’ala possente
Parve riempir la prigione,
Poiché il
Signore della Morte dal gelido fiato
Era entrato per uccidere.
Non passò
avvolto di purpureo fasto,
Né cavalcava un corsiero bianco al par di
luna.
Tre metri di
corda ed un asse scorrevole
Son tutto ciò che occorre per la forca:
Così con la
corda dell’obbrobrio venne l’Araldo
Per compiere la sua opera segreta.
Eravamo come
gente che in una palude
Di sozza tenebra brancoli:
Non osammo
alitare una preghiera
O dare sfogo all’angoscia:
Qualcosa era
morto in ognuno di noi,
E ciò che era morto era la speranza.
La truce
giustizia dell’uomo segue il suo corso
E mai non devia:
Abbatte il
debole, abbatte il forte
Con il suo passo semina la morte:
Con tallone
di ferro schiaccia il forte,
Il mostruoso parricida!
Aspettavamo
il battere delle otto
Con la lingua ispessita dalla sete:
Poiché alle
otto batte il destino
Che d’un uomo fa un maledetto,
E il destino
si serve d’un nodo scorsoio
Tanto per il migliore che per il peggiore.
Tanto per il migliore che per il peggiore.
Non potevamo
fare altro
Che attendere il segno imminente:
Come cose di
pietra in una valle sperduta
Sedevamo immobili e muti;
ma il cuore d’ognuno
dava battiti rapidi e cupi,
Come su un
tamburo un demente.
Con un colpo
improvviso l’orologio della prigione
Percosse l’aria fremente,
E dal carcere
intero eruppe un gemito
Di disperazione impotente,
Simile al
grido che odono le paludi sgomente
Dalla tana di un lebbroso.
E come si
vedono le più spaventevoli cose
Nel cristallo d’un sogno,
Vedemmo la
corda di canapa oleosa
Appesa alla trave nera
E udimmo la
preghiera
Che il laccio del boia in un urlo strozzò.
Tutto il
dolore che lo lacerò
Fino a strappargli quell’amaro grido,
E i furiosi
rimpianti, i sudori di sangue,
Nessuno al pari di me li poté capire:
Poiché colui
che vive più di una vita
Più di una morte deve morire.
IV
Non si va in
cappella il giorno
In cui
impiccano un uomo:
Il cappellano
ha troppo male al cuore,
O sul suo
volto c’è troppo pallore,
O nei suoi
occhi sono scritte cose
Che nessuno
deve vedere.
Così ci
tennero rinchiusi fin quasi a mezzogiorno,
Poi suonarono
la campana,
E con le loro
chiavi tintinnanti i guardiani
Aprirono le
celle intente in ascolto,
E noi
scendemmo pesantemente le scale di ferro,
sbucando ognuno
dal suo isolato inferno.
Uscimmo nella
dolce aria di Dio,
Ma non al
modo consueto:
La faccia
dell’uno sbiancata dalla paura,
La faccia
dell’altro era grigia,
Ed io non
vidi mai uomini tristi guardare
Così
intensamente la luce.
Uomini tristi
non vidi mai che guardassero
Con sì
intensa pupilla
La breve
tenda azzurra
Che noi
reclusi chiamavamo cielo,
E la nuvola
spensierata che in alto passava
In lieta
libertà.
Ma v’erano
alcuni tra noi
Che a testa
bassa incedevano,
Ben sapendo
che, se ognuno avesse ciò che si merita,
Sarebbe
toccato a loro morire:
Egli aveva
soltanto ucciso una cosa vivente
Essi ciò che
era già morto.
Poiché chi
pecca una seconda volta
Desta
un’anima morta al patimento,
La trae dal
macchiato sudario
E la fa
sanguinare nuovamente,
Sanguinare la
fa con grosse gocce di sangue,
E la fa
sanguinare vanamente!
Come scimmie
o pagliacci, in mostruoso costume
Di storte
frecce stellato,
Silenziosamente
andavamo muovendoci in cerchio,
Intorno al
cortile di sdrucciolevole asfalto;
Silenziosamente
andavamo muovendoci in cerchio
E nessuno
diceva una parola.
Silenziosamente
andavamo muovendoci in cerchio,
E nella
svuotata mente d’ognuno
Il ricordo di
cose terribili
Irrompeva
come un terribile vento:
Dinanzi a
ognuno incedeva l’Orrore
E dietro strisciava
il Terrore.
Tronfi i
guardiani andavan su e giù,
Vigilando il
loro armento di bruti;
Indossavano
uniformi nuove fiammanti,
I loro panni
domenicali,
Ma noi
capimmo a quale lavoro avessero atteso,
Dalla calce
che avevano sugli stivali.
Dove larga poc’anzi
una tomba s’apriva,
Non c’era più
tomba alcuna:
Solo una
striscia di terra smossa e di sabbia
Lungo
l’orrendo muro del carcere,
E un piccolo
mucchio di calce ardente
Affinché
l’uomo avesse un sudario.
Ed ha invero
un sudario, il disgraziato,
Quale pochi
possono pretendere:
Ben giù,
sotto un cortile di prigione,
Ignudo per
maggiore sua vergogna,
Giace, con le
catene ad ambo i piedi,
Avviluppato
in lenzuolo di fiamma!
E senza posa
la calce ardente
Rode le carni
e le ossa,
Rode le
fragili ossa di notte,
Le teneri
carne di giorno:
Rode ora le
carni, ora le ossa,
Ma sempre
rode il cuore.
Per tre
lunghi anni non semineranno
Né
pianteranno laggiù:
Per tre
lunghi anni il sito maledetto
Sarà sterile
e nudo,
E guarderà
l’attonito cielo
Con uno
sguardo privo di rimproveri.
Secondo loro,
un cuore d’omicida
Corromperebbe
ogni semplice seme che venisse deposto.
Non è vero!
La buona terra di Dio
E’ più buona
di quanto gli uomini non sappiano,
E la rosa
rossa si schiuderebbe semplicemente più rossa,
La rosa bianca
più bianca.
Dalla sua
bocca una rosa vermiglia,
Dal suo cuore
una bianca!
Perché chi
può dire per quali vie misteriose
Cristo riveli
la sua volontà,
Se l’arido
bastone del romeo
Fiorì al
cospetto del grande pontefice?
Ma né la
lattea rosa, né la rossa
Possono
fiorire in aria di prigione:
Ciottolo,
coccio, selce,
Ecco che cosa
ci danno:
Poiché si sa
che i fiori talvolta guariscono
La
disperazione dell’uomo.
Così né la
rosa rossa come vino né la bianca
Si
sfoglieranno mai petalo a petalo
Su quella striscia
di terra e di sabbia
Lungo
l’orrendo muro del carcere,
Per dire a
coloro che camminano per il cortile
Che il
Figliuolo di Dio morì per tutti.
Ma benché
l’orrendo muro del carcere
Ancora da
ogni parte lo rinserri,
E uno spirito
non possa errare la notte
Se da catene
è avvinto,
Né possa far
altro che piangere
Se giace in
così empio recinto.
E’ in pace il
disgraziato,
E’ in pace, o
quanto prima lo sarà:
Più non lo fa
impazzire cosa alcuna,
Né il Terrore
s’aggira in pieno giorno,
Poiché la
buia terra dove giace
Non ha sole
né luna.
L’hanno
impiccato come s’impicca una bestia:
Non hanno
nemmeno suonato
Un funebre
rintocco che avrebbe potuto
Calmare la
sua anima atterrita
Ma in fretta
e furia via l’hanno portato
E nascosto in
una buca.
L’han
spogliato dell’abito di tela
E abbandonato
alle mosche:
Han deriso la
gola paonazza ed enfiata,
Gli occhi
vitrei e sbarrati:
Con alte risa
hanno ammucchiato il sudario
In cui riposa
il loro condannato.
Il cappellano
non s’inginocchierebbe a pregare
Presso la sua
disonorata tomba,
Né la
segnerebbe con quella croce benedetta
Che Cristo
diede per i peccatori,
Perché l’uomo
era uno di coloro
Che Cristo
venne a salvare.
Ma non
importa: egli è semplicemente giunto
Allo sbocco
prefisso della vita:
E lacrime
d’estranei riempiranno per lui
L’urna della
Pietà da lungo infranta,
Perché lo
piangeranno i reietti,
E i reietti
piangono sempre.
V
Io non so se le leggi abbian ragione,
Io non so se le leggi abbian ragione,
O se le leggi
abbian torto;
Tutto ciò che
sappiamo, qui in prigione,
E’ che le
mura sono forti
E che ogni
giorno è simile ad un anno,
Un anno in
cui i gironi sono lunghi.
Ma questo so:
che ogni legge
Dagli uomini
fatta per l’uomo,
Fin dalla
prima volta che un uomo tolse la vita al fratello
Ed ebbe
inizio un mondo di triste travaglio,
Disperde il
grano e conserva la pula
Con un
pessimo vaglio.
Anche questo
io so – e sarebbe bene
Se tutti lo
potessero sapere –
Che ogni
prigione costruita dagli uomini
Con mattoni
di infamia è costruita,
E munita di
sbarre affinché Cristo non abbia a vedere
Come gli
uomini mutilano i loro fratelli.
Con sbarre
oscuran la graziosa luna
E accecano il
buon sole:
E fanno bene
a nascondere il loro inferno,
Perché vi
avvengono cose
Che né il
Figlio di Dio né il figlio dell’uomo
Dovrebbero
vedere giammai.
Le più vili
azioni come erbe velenose
Prosperano
nell’aria della prigione;
Solo quanto
di buono vi è nell’uomo
Vi si guasta
e intristisce:
La pallida
Angoscia sta al pesante portone
Ed è
guardiana la Disperazione.
Ché fan
patire la fame al bimbetto spaurito
Fin che dì e
notte piange,
E frustano il
debole, sferzano l’idiota,
Beffano il
vecchio dai capelli grigi,
E alcuni
impazziscono, e tutti diventan cattivi
E nessuno può
dire una parola.
Ogni angusta
cella nella quale abitiamo
E’ una sozza
e buia latrina;
Il fetido
fiato della Morte vivente
Soffoca ogni
finestra a inferriata;
E tutto,
fuorché il Desiderio, si sbriciola in polvere
Nella
macchina dell’Umanità.
L’acqua
salmastra che da noi si beve
Fluisce densa
di schifosa melma,
L’amaro pane
che ci pesano con le loro bilance
E’ pieno di
gesso e di calce,
e il Sonno
non si stende, ma cammina
Sbarrando gli
occhi e lancia grida al tempo.
Ma sebbene la
magra Fame e la livida Sete
Come l’aspide
e la vipera si diano battaglia,
Poco curiamo
del vitto del carcere:
Ciò che
davvero ci agghiaccia ed uccide
E’ che ogni
pietra alzata nel corso del giorno
Diventa poi
di notte il nostro cuore.
Sempre con la
mezzanotte nel cuore
E nella cella
il crepuscolo,
Giriamo la
manovella, sfilacciamo la corda,
Ognuno nel
suo inferno separato,
E assai più
spaventevole è il silenzio
Che il suono
d’una bronzea campana.
E mai non si
avvicina voce umana
Per dire una
parola di bontà:
L’occhi che
guarda traverso la porta
E’ duro e
senza pietà:
E da tutti
dimenticati andiamo sempre più imputridendo,
Nell’anima e
nel corpo rovinati.
Così arrugginiamo
la ferrea catena della Vita,
Degradati e
soli:
Alcuni
maledicono, altri piangono,
Altri non
danno lamenti:
Ma le eterni
leggi di Dio sono clementi
E spezzano il
cuore di pietra.
Ed ogni cuore
umano che si spezza
In cella od
in cortile di prigione
E’ come il
vaso infranto che largì
Il suo tesoro
al Signore
E nell’immonda
casa del lebbroso
Sparse un
olezzo di nardo prezioso.
Ah, beati
coloro il cui cuore può infrangersi
E conquistare
la pace del perdono!
Come
altrimenti potrebbe l’uomo raddrizzare le sue vie
E l’anima
mondare dal peccato?
Come, se non
per il varco d’un cuore spezzato,
Cristo
Signore in lui potrebbe entrare?
E l’uomo
dalla gola paonazza ed enfiata,
Dai vitrei
occhi sbarrati,
Le mani sante
attende che portarono
Il ladro in
paradiso:
Poiché il
Signore non sprezza
Un cuore
infranto e contrito.
L’uomo in
rosso che interpreta la Legge
Gli concesse
tre settimane di vita,
Tre brevi settimane
per guarire
L’anima dal
suo intimo conflitto
E per lavare
da ogni macchia di sangue
La mano che
aveva impugnato il coltello.
E con lacrime
di sangue egli deterse la mano,
La mano che
aveva stretto la lama d’acciaio:
Poiché soltanto
il sangue può il sangue lavare,
E soltanto le
lacrime sanare:
E la rossa
macchia che già fu di Caino
Divenne il
nìveo sigillo di Cristo.
VI
Nel carcere
di Reading presso la città
V’è una fossa
d’infamia,
E là giace
uno sventurato
Roso da denti
di fiamma:
Il bruciante
sudario è avviluppato.
E sopra la
sua tomba non v’è nome.
Là, fin che
Cristo chiami fuori i morti,
In silenzio
lasciatelo dormire:
Inutile
sprecare sciocche lacrime
O trarre vani
sospiri:
Quell’uomo
aveva ucciso ciò che amava,
E quindi
doveva morire.
Ed ogni uomo
uccide ciò che ama,
Lo intendano
tutti:
Lo fanno
alcuni con bieco sguardo
Ed altri con
parole carezzevoli,
Il vile con
un bacio,
il prode con
la spada!
C.3.3.
..........................................................................................................................
- disegni e immagini: fonte Internet appartenenti ai legittimi proprietari
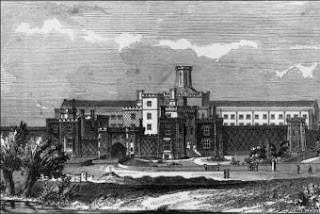







Un omaggio a Wilde
RispondiEliminastupendo
RispondiEliminaun'opera di una forza unica. oggi più attuale che mai.
RispondiElimina